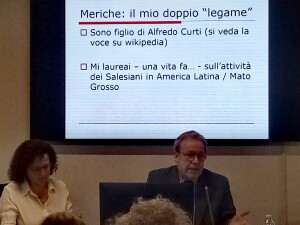Francesca Rossi, eccellente allieva della sesta edizione dei corsi di qualifica regionale GAE (Guida Ambientale Escursionistica), mi invia un proprio – pregevole – elaborato sul vitigno e vino Lumassina di cui già mi aveva accennato a lezione. Lo scrisse qualche anno or sono per l’esame di “Antropologia dei beni culturali immateriali” nel master in “Promozione e organizzazione turistica e culturale del territorio”, e concretizza un itinerario alla riscoperta della Lumassina, tradizionale nel Finalese, corredato anche da significative interviste.
Francesca mi “promette” che, superato l’impegnativo esame che la attende, mi produrrà specificamente un articolo per Ligucibario®.
Apro tuttavia il pdf, il quale subito mi conduce dentro un àmbito d’entroterra contadini (Valle dell’Aquila e Orco Feglino) che mi è in gran parte noto, ma che tuttavia non cessa di coinvolgermi. Fasce terrazzate da muretti a secco, vigneti tenuti sù col particolare sistema detto “ambrustin” (pali di castagno grezzo collegati da rami di salice), antiche contese feudali, feste di paese, agriturismi, là dove via via mare e falesie cedono il passo ai declivi boscosi, raggiungendo infine le “colle” sull’Alta Via e i 1.000 metri della faggeta del Melogno…
Quando, in aula o in occasione di conferenze, racconto l’ampelografia ligure, lumassina è vitigno dagli innumerevoli sinonimi, che possono un po’ confondere le idee: buzzetto a Quiliano e dintorni, mataossu anzitutto a Varigotti, garella a Savona, üga matta a Spotorno, acerbina qui e là… Molti viticoltori, nel tempo, lo abbandonarono, a vantaggio dei più “prevedibili” vermentino, pigato, rossese. Io lo conobbi una vita fa, ma proprio una vita fa, pranzando all’Osteria di Castel Gavone sù a Perti, in compagnia di mio padre, e di una cameriera che s’ostinava a chiamarlo “nonno”. Direi che quel vino oggi è molto migliorato, e costituisce un’ottima risorsa per abbinare molteplici specialità liguri.
Lumassina deriva probabilmente il proprio nome dalle lumache, molto diffuse sul territorio, il Buzzetto viceversa da “buzzo”, cioè acerbo, aspro, e il Mataossu da “precoce, neonato”, ovvero non matura pienamente.
E’ tipico come detto delle aree anzitutto finalesi. Arriva in Liguria, secondo studiosi, nel ‘300, ma i primi scritti sono ottocenteschi, per merito ad esempio del Di Rovasenda. Ha raccolta un po’ ritardata e talora si vinificava con altre uve per la sua buona acidità e l’intenso floreale. Personalmente lo accompagno a frittate, farinate, panisse, polpettoni, e a fritturine di pesce, anche e ancor più nelle versioni spumantizzate.
Del Buzzetto così scriveva lo chef savonese Ferrer Manuelli: “Quando i grappoli erano quasi maturi, si sfogliavano e poi si incappucciavano con un sacchetto di carta per proteggerli dalle api e dalle vespe. La carta naturalmente doveva essere filtrante, affinché gli acini potessero respirare. Una volta poi colti, i grappoli venivano ancora esposti al sole, sopra un graticcio, sul terrazzo di casa, fino ad appassire, dopo di che si pigiavano in un barile. Si lasciava fermentare il mosto per pochi giorni, lo si rimetteva al pulito, lo si restringeva ed infine si imbottigliava il vino lasciandolo poi riposare fino al primo parto, in famiglia, o fino all’ora del dessert dopo il pranzo di Natale”.
Francesca, attendo ora il tuo articolo…
Umberto Curti