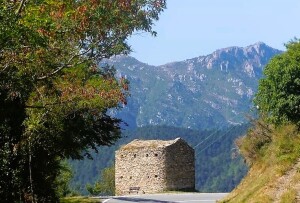Il Dizionarietto GAE di Umberto Curti
Repertorio di termini e concetti ad uso degli allievi dei corsi GAE presso l’ente F.Ire di Genova.
Per approfondimenti si raccomanda anche la richiesta all’editore (link qui) del mio saggio “Sostenibilità e biodiversità. Un Glossario” (2023), che verrà spedito (gratuitamente)in formato pdf…
Si suggerisce agli allievi l’uso di una buona cartina regionale, così da georeferenziare ove necessario quanto segue.
Parte 9 (di 15)
Maggese: la parola deriva da maius (maggio), perché in quel mese si solevano dissodare i campi. E’ una tecnica agricola antica per cui terreni arabili vengono lasciati senza semina per uno o più cicli vegetativi al fine di incrementarne la fertilità. Il termine tuttavia indica, per estensione, anche quel terreno nonché il complesso delle operazioni che si effettuano… Il maggese può non di rado risultare sinergico alla (positiva) pratica della rotazione delle colture, che previene/fronteggia l’impoverimento del terreno
Malga: è in genere una struttura abitabile, con stalla. Gli alpeggi sono i prati tutt’attorno, dove il bestiame pascola. Le malghe sono sovente comunali, o di consorzi che possono affidarle in gestione. Tradizionalmente sono “evolute” anche in agriturismi/fattorie didattiche… Formaggio di malga (ovvero da latte di animali che pascolano in altura) è – tendenzialmente – espressione usata più nell’Italia di Nord Est
Matricina: nei boschi cedui è un albero che viene risparmiato, per rimpiazzare le vecchie ceppaie che vengono eliminate dal taglio di disbosco. Erano celebri le matricine “di Benevento” (se ben ricordo dal nome di una cascina), 5 enormi faggi presso la Colla di San Giacomo (SV), importante crocevia escursionistico
Maxei: sono i muretti a secco. Maxea sta per maceria, in quanto venivano costruiti – per sbarrare, sorreggere, far da siepe… – “approssimativamente”, con mucchi di pietre. In realtà, è un’antica arte costruttiva divenuta alcuni anni fa patrimonio Unesco e per la quale si organizzano corsi di formazione…
Mediterraneità: “valore” ambientale e storico-culturale che l’Italia – e la Liguria – condividono con gli altri Paesi che s’affacciano su quel che i Romani chiamavano “mare nostrum”. Si consiglia in proposito anzitutto la (magnifica) lettura di saggisti quali Fernand Braudel e di Predrag Matvejevic, e la visione di docufilm quali ad esempio “Alla ricerca di Europa” di Alessandro Scillitani. Si noti che da alcuni anni anche la cosiddetta dieta mediterranea è assurta, non a caso, a patrimonio Unesco…
Megaliti: dal greco, letteralmente grandi pietre. Sono distribuite su Europa, Africa, Asia, ma Bretagna e isole britanniche propongono – per così dire le une di fronte all’altra – la concentrazione più rilevante. Gli storici hanno dimostrato che alcune (si pensi appunto ai menhir) rivestirono in passato significati cultuali/funerari. Possono presentarsi singole o “riunite” in gruppi. La Liguria propone casi a Pieve di Teco, Camporotondo (Finale Ligure), Varazze, Monte Caprione (tra Lerici e Ameglia), Tramonti… I megaliti si differenziano dai dolmen, i quali sono tombe-altari costituite da due o più piedritti verticali che sorreggono un’architrave, di solito una o più lastre orizzontali. La costruzione era in origine ricoperta, protetta e sostenuta da un tumulo. La Liguria propone casi – ben conservati – anzitutto nel Savonese, a Valzemola (Roccavignale), a Verezzi…
Merello, Rubaldo: se vi è un pittore, fra i “vedutisti”, che forse più d’ogni altro ha rappresentato nelle proprie tele la biodiversità del Levante ligure, quello – senza con ciò sminuire la “Scuola dei Grigi” e tutto quel che Telemaco Signorini dedicò a Riomaggiore – è Rubaldo Merello… Morì nel 1922 appena cinquantenne, dopo una vita vissuta non di rado, malgrado alcune affermazioni professionali, in solitudini e romitaggi – contribuì ai suoi smarrimenti anche la perdita di un figlio in tenera età, nel 1913 – . Valtellinese di Isolato (ma con un padre di antiche origini genovesi), arrivò a Genova negli anni ’80 dell’Ottocento, ancora ragazzetto, seguendo l’iter di una formazione classica e poi l’Accademia Ligustica di Belle Arti, dove conobbe capaci maestri e dove si distinse (ma ben poco altro conosciamo della sua biografia…). Completati gli studi aprì un atelier a Genova-Nervi. Non fu peraltro solo pittore, ma anche raffinato disegnatore e scultore… La corrente cui più s’accostò fu il Divisionismo post impressionista, “frequentando” Plinio Nomellini (da cui trasse i forti slanci istintuali e spirituale che “scagliava” sulla tela), Giovanni Segantini, Gaetano Previati*, Giuseppe Pellizza da Volpedo (che morì purtroppo suicida nel 1907). La costa ligure (il Monte di Portofino, Punta Chiappa, Camogli e San Fruttuoso, la Ruta!) dove Merello abitò a lungo rappresentò il suo pressoché continuo tema ispiratore, ma rappresentata con una “energia” nei colori sovvertitrice, via via estranea ai tonalismi di Ernesto Rayper (1840-1873) e della sunnominata Scuola “grigia” o “dei grigi”. Scogli, battigie, alberi, crespuscoli…, colpi di luce, la natura che avvampa, mari rossi… Merello fu infatti un figurativo molto sui generis, e difatti risulta ancora attuale per il nostro gusto di contemporanei, e la cromia delle sue opere si fa portatrice di un “espressionismo” che immette nei paesaggi anche lo stato d’animo, l’immediato mood interiore dell’artista…
*che scrisse I principi scientifici del Divisionismo, edito a Torino nel 1906.
Meteo: come noto, ove l’escursione si svolga in contesti montani le condizioni meteo possono mutare velocissimamente. E’ dunque indispensabile, grazie a siti ed app dedicate, essere aggiornati circa l’evolvere della situazione locale, e – ove necessario – limitare/modificare o interrompere il percorso.
Mezzero: dall’arabo mizar (celare, coprire), è un grande quadrato di cotone o lino riccamente stampato, anzitutto con originali motivi di piante (il più noto è verosimilmente “l’albero della vita”) e colorati fiori. Con tale panno (usato anche negli arredi delle dimore patrizie) le donne genovesi e liguri si drappeggiavano già nel ‘200, sebbene molti motivi risalgano poi ad epoche successive, al ‘600…
Miniera di Gambatesa: è una miniera di manganese nel Comune di Ne (GE). Visitabile tramite un percorso su vagoncini, risulta meta molto gettonata anzitutto dalle famiglie con bambini… Verificare sempre giorni e orari di apertura
Mobilità dolce: l’aggettivo allude ad una modalità di trasporto (anzitutto di persone) che punta a preservare l’ambiente attraverso un maggior utilizzo di mezzi pubblici o green, come le biciclette e le auto elettriche, per spostarsi all’interno dei centri urbani o tra Comuni limitrofi. Ad essa si integrano positivamente specifici incentivi (come il “pin bike” adottato anche da alcune città italiane quali Bergamo, Torino, Bari, Pescara…*), e, ove l’auto risulti viceversa indispensabile, il car pooling (covoiturage), il car sharing… A latere, sono nati un po’ ovunque movimenti car-free per rendere le strade cittadine più vivibili, si veda ad es. l’esperienza di Vauban (quartiere sud di Friburgo, in Germania**)… Lo stesso celebre architetto e urbanista Léon Krier ha scritto numerosi saggi (molti già sul giornale Architectural Design degli anni ’80 del Novecento) contro la pianificazione modernista che scisse e scinde le città in àmbiti “tirannicamente” funzionali (residenziale, industriale, commerciale, ecc.), costringendo il cittadino ad onerosi e lunghi spostamenti quotidiani, sovente da una periferia (ring) verso un centro, sempre troppo “distinti” e poco o mal collegati fra loro. Gli ingorghi cittadini in Europa, si badi, incidono anche sul PIL, con costi sociali – e sanitari – ormai vicini allo 0,5%. Va tuttavia sottolineato come molte città – anche diversissime tra loro – stiano adoperandosi per una “conversione”: a mero titolo d’esempio Parigi si è aperta trasformando le corsie preferenziali dei bus in ciclabili, con delineatori e segnaletiche; Valencia si è affidata ad un assessore (peraltro italiano), Giuseppe Grezzi, che ovunque si potesse ha pedonalizzato, incrementato il trasporto pubblico, creato piste ciclabili, abbassato i limiti di velocità; Pesaro col progetto “bicipolitana” ha associato la bicicletta al trasporto pubblico, con 98 km di piste ben diffuse e connesse; Ferrara, da sempre “favorita” in quanto città tutta pianeggiante, conta 107 km di ciclabili, su cui si muovono studenti e insegnanti, vigili urbani, tifosi della Spal quando la squadra di calcio gioca in casa…; Genova ha reso gratuiti alcuni mezzi pubblici, sotterranei e di risalita (metropolitana, funicolari, ascensori)… Quanto all’Olanda, Paese modello per le piste ciclabili, ¼ di tutti gli spostamenti urbani avviene ormai su due ruote, grazie ad una rete estesa per circa 360mila chilometri (e si compari perciò lo sconsolante dato italiano, fermo a circa 4mila chilometri, di cui circa il 60% urbani).
*all’estero Braga in Portogallo, Istanbul in Turchia, Tallin in Estonia…
**dove si è drasticamente ridotta la presenza delle auto, con pochi parcheggi situati al di fuori del quartiere. Il potenziamento dei mezzi pubblici ha infatti permesso al 40% delle famiglie di non aver praticamente bisogno dell’auto, perché è presente il car sharing, ma soprattutto perché coloro che non utilizzano il parcheggio godono di veri e propri incentivi economici…
Monet, Claude: straordinario pittore impressionista parigino (1840-1926), visse a Bordighera alla pensione “Anglaise” dal gennaio all’aprile del 1884, compiendo escursioni, facendo amicizie (fra cui il mercante d’olio Moreno) e soprattutto ritraendo i luoghi – i cui colori lo incantavano – dentro una quarantina di tele passate alla storia, fra cui “Il ponte e il castello” a Dolceacqua
Montale, Eugenio: nel 2025 ricorre il centenario della pubblicazione di “Ossi di seppia”, prima raccolta e primo capolavoro poetico di questo letterato genovese, che nel 1975 – al termine di un lungo “cammino” compositivo ergo umano – ricevette a Stoccolma dalle mani del sovrano il premio Nobel per la letteratura, «per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni». Genovese di nascita (una targa non lo dimentica in corso Dogali, ripida salita nel quartiere di Castelletto), di ceto borghese, ultimo di 6 figli, era ragazzino gracile di salute e fu iscritto a ragioneria, corso scolastico più “easy” rispetto al duro liceo classico, ma le sue attitudini e i suoi interessi già inclinavano chiaramente altrove; letteratura, poesia anche in lingua straniera, arte, musica e canto… Per esigenze di lavoro abitò sovente in altre città (Firenze, Milano in via Bigli prima all’11 poi al 15), ma riservandosi lunghi periodi a Monterosso (IM), la prima a ponente delle Cinque Terre, dove la famiglia possedeva una villa liberty, la “pagoda giallognola”, connotata da 2 slanciate palme… E quella mediterraneità vicino a Punta Mesco, brulla, assolata, tra agrumeti, insenature, risacche incessanti, muri a confine delle proprietà invalicabili per gli aguzzi cocci di bottiglia, viene immortalata frequentemente nelle liriche più ispirate. “Pure colline chiudevano d’intorno marina e case; ulivi le vestivano qua e là come greggi, o tenui come il fumo di un casale che veleggi la faccia cadente del cielo”… Sin dalla prima raccolta Montale, persona non spigliata ma autorevole, s’impose come una delle più peculiari voci del Novecento *, poiché teso a rappresentare in versi originali – benché qui e là ermetici – lo “spleen” di un’epoca (e di una generazione), alle prese con un secolo tutto nuovo e irrequieto. Utopistico, giocoforza, sarebbe riassumere più di tanto il suo percorso – pur poeta immenso, Montale non fu mai solo poeta – , circa il quale sono comunque leggibili chilometriche bibliografie. Antifascista per dna “culturale”, firmò proprio nel 1925 il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” di Benedetto Croce, una firma in chiave anti-Gentile e che – a lui come agli altri firmatari – costò parecchi grattacapi (tanto che nel 1939 dopo ripetuti “ammonimenti” fu esonerato dall’incarico di Direttore del prestigioso Gabinetto scientifico-letterario Viesseux di Firenze). Quantunque gli sia stato imputato di non aver mai trovato – e dunque spartito – un conforto a quel male di vivere che il poeta dal proprio io trasfonde in qualche modo all’intero creato **, così come di non aver dato idoneo prosieguo alla poetica alta, algida e però a tratti “civile” de La bufera e altro, Montale si staglia tuttora come voce schietta, voce irrinunciabile dentro un secolo vulnerato purtroppo da due stragi mondiali *** e da un succedersi di sconvolgimenti e di tecno-dominii cui via via l’uomo non sarebbe stato in grado di “adattarsi” (e in ciò Montale si lega – pur avversandolo – al miglior Pasolini?)… L’arte diventa perciò se non un rifugio una forma di vita “surrogata” per colui che la vita vera non vive (la vita non è vita se la morte è nella vita…), per chi non identifica l’anello che non tiene, e dunque rimane recluso a riva, incapace di scorgere un varco che lo affranchi… In politica, pre e post fascismo, fu lato sensu un conservatore, senza però mai aderire materialmente ad alcun partito, eccetto un brevissimo momento nel Partito d’Azione, un partito fondato nel 1942 con ispirazioni mazziniane. Confessò: «L’argomento della mia poesia (…) è la condizione umana in sé considerata: non questo o quello avvenimento storico. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa solo coscienza, e volontà, di non scambiare l’essenziale col transitorio (…). Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia.» Giace dal 1981 in un cimitero appartato nei sobborghi di Firenze, con l’amata moglie Drusilla Tanzi, che soprannominava “la Mosca” per gli smisurati e spessi occhiali da vista, e a cui dedicò la raccolta Xenia (xenia erano nell’antica Grecia i doni porti affettuosamente agli ospiti). Era stata, la Mosca, a lungo malata di spondilite prima di morire, e aveva supplicato “la Gina” (la domestica Gina Tiossi) di restare accanto al poeta, ciò che costei meritoriamente fece, fino alla fine…
*un secolo che in Liguria annoverò Mario Novaro (1868-1944), Giovanni Boine (1887-1917), Camillo Sbarbaro (1888-1967), Giorgio Caproni (1912-1990)…
**”Spesso il male di vivere ho incontrato, era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato”… Questi versi folgoranti figurano significativamente già dentro Ossi di seppia.
***Montale combatté durante la prima, col grado di sottotenente di fanteria, presso Vallarsa, in Trentino (in una poesia nomina le due frazioni di Cumerlotti e Anghebeni)
More than honey: splendido docufilm del 2012 diretto dal regista Markus Imhoof, nel quale si descrive un mondo in pericolo, poiché le api vanno estinguendosi a causa del sempre peggior rapporto con le attività umane. Sul tema, è visitabile in Liguria il Museo dell’apicoltura a Calice al Cornoviglio (SP), verificare sempre giorni e orari di apertura…
Mountain biking: “turismo” outdoor che in Liguria, presso alcune aree fra cui in primis il Finalese, è divenuto quasi preponderante rispetto all’escursionismo, tanto che alcune strutture ricettive si sono intensamente riconvertite in bike hotel, offrendo servizi su misura. I mtbikers prediligono il freeride fuori dai sentieri battuti, il cosiddetto downhill con salti, pietraie, ostacoli, ma sovente anche i “pistini” verticaleggianti
Mucca cabannina: è la sola razza autoctona della Liguria, particolarmente agile in quanto “abituata” ai declivi. S’incontra anzitutto in val d’Aveto, ed è animale a doppia vocazione, ovvero mungitura e carne (per sughi e polpette).
Mulattiera: percorso creato/utilizzato per il passaggio di carovane di muli o altri animali da soma
Mulino: struttura per la macinatura di cereali ed altro. La Liguria ne era punteggiata, ed alcuni sono ancora in attività (Sassello, Genova Pegli…). Significative possono essere anzitutto nel Genovesato le visite organizzate ad es. a Belpiano di Borzonasca, a Gramizza di Santo Stefano d’Aveto (mulino ad acqua dell’azienda agricola Fontana Liliana), a Tonno di Valbrevenna, a Neirone, a Sant’Olcese, a Fulle di Sori, al Mulino del Gassetta nel Parco di Portofino… E si consideri che Molini di Triora (IM) deve ai mulini proprio il toponimo.
Per info sui corsi, ente F.Ire, piazza G. Matteotti 2/3b, 16123 Genova, tel. 010 9820702, formazione@entefire.it