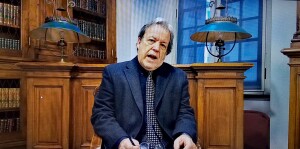Cenni per una storia della Liguria e di Genova
1)Origini, preistoria/protostoria
I Liguri sono uno dei più antichi popoli del Mediterraneo (culla di civiltà), e al contempo sono assai remote le prime testimonianze circa una presenza dell’uomo in Liguria. Tuttora si dibatte se si trattasse di una popolazione indoeuropea, casomai imparentata con popolazioni celtiche antiche, o preindoeuropea (glosse, relitti linguistici e toponomastica includono la lingua ligure fra le preindoeuropee di tipo mediterraneo). In termini – diremmo oggi – di melting pot, nel VI secolo a. C. coloni greci di Focea, in Asia Minore, avevano fondato Massalia (Marsiglia), e intorno al IV secolo si insediarono poi sul territorio “ligure” altre tribù celtiche e fenicie, contatti che ci ostacolano precise ascendenze etniche…
Liguria deriverebbe da un monema lig, che significherebbe luogo acquitrinoso, palude, golena, pantani stagnanti poco abitabili (lig originerebbe anche il toponimo francese Livière). Ma in effetti una terra definita dai diversi primi autori anche sassosa, sterile, aspra, o coperta di alberi da abbattere, quindi sempre inospitale, sempre un’orografia antitetica alle agricolture… “Schiacciata”, ieri come oggi, tra Alpi/Appennini da un lato e coste rocciose dall’altro (il Mar Ligure raggiunge rapidamente profondità superiori ai 1.000 m), con l’eccezione di alcuni arenili più ampi a Ponente e della sempre fertile piana d’Albenga, dove “convergeva” l’acqua di vari torrenti che poi vennero chiamati Pennavaire, Neva, Arroscia, Lerrone.
Durante il Paleolitico, il periodo dell’uomo cosiddetto di Nearderthal e dei cacciatori di orsi, in Liguria vivevano il cervo, lo stambecco, il camoscio, il capriolo, l’uro (estinto), il bisonte, l’ippopotamo, l’alce, il mammuth e il leone. Qui come in altre zone d’Italia, quali ad esempio la Puglia e la Sardegna, sebbene sia ormai difficile immaginarlo.
I primi Liguri lasciarono traccia di sé nella grotta del Cavillon ai Balzi Rossi a Grimaldi, oggi confine francese; nel territorio dell’attuale Sanremo; nel Loanese-Finalese (grotta delle arene candide (a), val Ponci←vallis pontium…) oltre che a Toirano; e, in misura minore, in altre località di levante (grotta dei colombi all’isola Palmària, l’unica non marina dell’arcipelago…).
Nelle grotte lungo il torrente Pennavaire, che dà nome alla valle tra Zuccarello e Cantarana, ovvero le aree ingauna e ormeasca, sono stati ritrovati residui umani risalenti fino al 7.000 a.C. Via via scavi mirati e accurati, presso i Balzi Rossi e altri siti, hanno restituito agli archeologi molti materiali, tra cui resti fossili, importanti per comprendere l’alimentazione del tempo, sepolture con oggetti di corredo (il medico Emile Rivière aveva scoperto la prima alla grotta del Cavillon alla fine di marzo del 1872), ed inoltre talune fra le prime espressioni d’arte conosciute in Italia e nel bacino mediterraneo, si pensi anche alle circa 40mila incisioni rupestri di Monte Bego nella valle delle Meraviglie, risalenti all’età del rame/bronzo. Alla successiva età del ferro o poco prima (Neolitico) risalgono anche i castellari, stazioni fortificate dove poter vivere sorvegliando e fronteggiando i passaggi nemici, e le straordinarie (enigmatiche) statue-stele oggi riunite nel Museo del Piagnaro a Pontremoli, in Lunigiana (la prima statua stele giuntaci venne rinvenuta nel 1827 a Novà di Zignago (SP), e reca l’iscrizione etrusca “mezunemunius”). E’ certo che quei Liguri abitassero una regione molto più estesa dell’attuale, quantomeno dall’Arno al Rodano→Ebro, come è stato scritto (b). Tuttavia, nel ‘300 l’Alighieri, valutando anzitutto l’aspetto linguistico-dialettale, parlerà della Liguria come di una regione compresa tra il “trofeo d’Augusto” (La Turbie) ad ovest, Lerici ad est, e lo spartiacque alpino-appenninico. Il patrimonio archeologico ligure compone un fil rouge trasversale, che in termini turistici attende da sempre una compiuta valorizzazione d’insieme.
(a) celebre per il rinvenimento della sepoltura di un “giovane principe”, un cacciatore del Paleolitico superiore deceduto circa 15enne per via di un forte colpo al volto, e seppellito nella cavità con gli onori che si tributano ad un capo, accompagnato da un cospicuo corredo.
(b) per ulteriori approfondimenti, vedi ad es. Umberto Curti, “Il cibo in Liguria dalla preistoria all’età romana”, ed. De Ferrari, Genova, 2012…
2)Romanizzazione
La Liguria, ancora tribale e “primitiva” due secoli e mezzo prima di Cristo, suddivisa in gruppi apuani, ingauni, intemelii ecc., praticanti una modesta economia agro-pastorale (integrata da caccia e pesca) ma bellicosi, fu quindi conquistata dai Romani, potenza per natura espansiva. Per quanto attiene a Genova, il nucleo pre-romano fu la rupe di Sarzano, sorta poi di oppidum sopra il navigatissimo seno del Mandraccio, oggi la “collina di Castello”.
Durante la prima guerra punica (238-235 a.C.), a seguito dell’alleanza di alcune tribù liguri – ma mai i Genuates! – coi Cartaginesi e coi Galli contro Roma, i Romani dovettero superare molte difficoltà per assicurarsi il controllo del territorio, che pian piano divenne – malgrado la guerriglia di gruppi liguri rimasti “autonomi” – la IX Regio augustea. Dopo le distruzioni del 205 a.C. provocate dai Cartaginesi di Magone Barca – fratello minore di Annibale – nel corso della seconda guerra punica, si verificò nell’attuale area di Genova una spinta abitativa a nord ed est, “popolando” quelle prime alture che (la storia si ripete “curiosamente”) molti secoli dopo divennero i luoghi di villeggiatura della nobiltà cittadina in fuga dalla calura.
Apuani e ingauni, nel corso della conquista romana, vennero ripetutamente massacrati e deportati (182-180 a.C.). Tuttavia, solo con la costruzione delle grandi strade romane (ovvero 1.la via Julia Augusta da Vada al Var in Provenza; 2.la via Postumia, da Derthona (Tortona) a Genova (visibili alcuni resti di Libarna), che collegava il mare alla Padania e alle “autostrade” direzionate all’Adriatico; 3.la via Aemilia Scauri, da Luna a Vada e a Derthona), i Romani poterono finalmente assicurarsi la sottomissione e il controllo definitivo della regione posta tra Pisa/Magra a levante e Roja/Aquae Sextiae (oggi Aix-en-Provence) a ponente, rafforzandone l’unità territoriale ed incrementando gli scambi ed il business dei commerci. I Romani confermarono, per così dire, come principali città Albintimilium (Ventimiglia), di cui rimangono significativi monumenti; Albingaunum (Albenga), anch’essa ricca e splendida, area agricola su cui giunsero subito ad insediarsi facoltosi coloni, e che “dialogava” con Aquae Statiellae e Alba Pompeia; Vada Sabatia (Vado Ligure), scalo come oggi di valenza portuale; Ad Navalia (Varazze) dove i conquistatori ricavavano dal Beigua tronchi per costruire la flotta mercantile e militare; Genua (da un etrusco Kainua, Genova), emporio per l’import ed export sin dall’epoca etrusca, scalo delle “portacontainer” che trasferivano merci – ad es. vini e olii – sulle rotte da Roma alla Spagna, e ritorno (c). E infine la bella marmorea Luna (Luni), il porto a forma di luna, da cui salpavano anche formaggi di pregio, verosimilmente ovini e rotondi, di cui parla in un epigramma il salace poeta Marziale («caseus etrusca signatus imagine Lunae praestabit pueris prandia mille tuis», il cacio contrassegnato dal simbolo etrusco di Luni procaccerà mille pasti ai tuoi fanciulli/servi), vissuto nel I secolo d.C..
(c) nel 1506 un contadino della val Polcevera, tal Agostino Pedemonte, ritrova presso Serra Riccò (GE), nel rio Pernecco, ivi portata da un moto franoso, una tavola di bronzo, che poi verrà datata al 117 a.C., contenente un testo in latino. Si tratta di un arbitrato emesso da magistrati a Roma per dirimere la contesa fra “Genuates” (Genovesi) e “Viturii Langenses” (abitanti di Langasco, in val Polcevera). Questi ultimi dovranno pagare un vectigal, una sanzione (in grano e vino) onde poter fruire del compascuus, ovvero il terreno pubblico su cui far pascolare le mandrie ecc.. La tavola bronzea, restaurata alcuni decenni or sono e oggi visibile al Museo civico archeologico di Genova Pegli, è la conferma di come in zona – lungo l’importante via Postumia… – si praticasse al tempo già anche la viticoltura (ed oggi la val Polcevera è una delle 8 DOC vinicole liguri…)
3)Epoche “barbariche” ed Alto Medioevo
Caduto via via l’impero romano, il territorio ligure fu ovvia e ambita meta delle invasioni barbariche, dei Visigoti di re Alarico (morto nel 410), degli Eruli di Odoacre (morto nel 493) e dei Goti di Teodorico (morto nel 526)… Genova fu certamente e precocemente sede vescovile, come si evince – leggendo gli Acta Concilii – dalla presenza di Diogene (con funzione anti-arianesimo) al Concilio d’Aquileia del 381, un sinodo “politicamente” decisivo per la Cristianità. Conquistata dall’audace e abile generale Belisario, la Liguria di fatto fu poi bizantina. I bizantini, che abitavano i “resti” dell’Impero romano d’oriente, per l’importanza dei suoi porti la tennero a lungo, difendendo anzitutto la costa contro le mire esterne. In seguito e per un paio di secoli fu dominata anche dai Longobardi “di Rotari”, che naturalmente applicarono l’editto di Rotari (643) e permisero la fondazione di diverse abbazie, dato che molti monaci – in primis poi i benedettini – erano agronomi e speziali di grande cultura (è di pochi decenni antecedente all’editto di Rotari l’insediamento dell’irlandese Colombano a Bobbio, e si suppone che l’editto, un corpus di norme per dirimere controversie, sia stato redatto proprio nello scriptorium di Bobbio, dove si fabbricavano anche pergamene…). Non si devono figurare le calate barbariche sempre in forma di scorrerie selvagge: i nuovi venuti “scendevano” sovente con famiglie e bestiame, per insediarsi e campare stabilmente.
Il porto di Genova divenne porto franco, e si sviluppò nei retrostanti entroterra la coltivazione a terrazze, ovvero fasce sostenute da muretti a secco (quest’arte appartiene oggi al patrimonio UNESCO), mentre riprendevano alcuni commerci.
Presa poi dai Franchi, che avevano sconfitto alle chiuse in val di Susa i Longobardi nel 773-774, la Liguria subì anche ripetute aggressioni saracene e normanne. Tali razzie comportavano anche stupri e rapimenti, impattavano gravemente sul morale e l’economia locale, e indussero molte località “in prima linea” ad erigere strutture e torri di avvistamento sugli arenili, di cui talora ci resta traccia. Sconfitti o quantomeno fronteggiati i Saraceni (nel 952 venne distrutto l’avamposto del Frassineto – La Garde-Freinet – in Provenza e quindi la minaccia islamica che da alcuni decenni tormentava anche Genova ne uscì notevolmente diminuita), dopo il Mille le attività commerciali ripresero pian piano vigore.
4)Medioevo e progressiva affermazione mercantile di Genova
Intanto la Liguria dei Franchi era stata divisa da Berengario II d’Ivrea in tre marche “fedeli”, da cui provengono le maggiori dinastie di quel tempo: l’Arduinica ad occidente, l’Aleramica al centro, e l’Obertenga (con Genova e La Spezia) ad Oriente. Nei secoli XI e XII le marche sopracitate furono frazionate in feudi. Feudo deriverebbe da un franco/germanico fehu, ovvero possesso di bestiame.
È a questo punto (alquanto tranquillo) della storia ligure che in effetti Genova si afferma durevolmente, e più d’ogni altro centro ligure.
Elevata a rango di contea in epoca carolingia contro i Saraceni, i quali in varie occasioni la percorsero e ripercorsero con l’usuale puntualità (sino agli anni 931, 934, 945…), divenne successivamente, come detto, Marca Obertenga, cioè feudo dei marchesi Obertenghi. Lo stato di fatto, sin dal 958, consentì ai Genovesi molte prerogative di relativa libertà, dentro quelle cinte murarie che una dopo l’altra venivano issate a contrasto anzitutto degli Arabi. E’ del 1056 l’autonomia cittadina grazie ad un accordo stipulato fra il vescovo e – appunto – i marchesi Obertenghi. Genova, pertanto, assurse a libero Comune che “aggregava” in sé le antiche compagne commerciali di rione; in tal senso, possiamo affermare che i Comuni sono stati null’altro che la prima forma forte di associazionismo. Tale indipendenza, unitamente al valore strategico delle sue coste ed ai valichi, consentì a Genova una prima significativa espansione verso occidente, ed alcune compagne poterono già schierarsi a fianco dei pisani, al tempo ancora alleati, nella navigazione del Mediterraneo centrale. Fu il preludio alle Crociate del XI secolo, che cominciarono a fruttare nuove relazioni e molteplici colonie d’oltremare. Genova nel 1091 insediò addirittura un mega-mercato a San Giovanni d’Acri. Al 1155 risalgono la celebre Porta Soprana e la cinta muraria eretta contro la minaccia di Federico Barbarossa, all’epoca un bellicoso 33enne, incoronato “re dei Romani”. Il governo della Sicilia fece ulteriormente di Genova l’emporio nodale del Mediterraneo, mentre ferveva l’escalation delle Maone, sodalizi privati (molto se ne è scritto anche recentemente) di carattere finanziario-politico grazie alle quali si realizzeranno poi le missioni – altrimenti inimmaginabili – per la presa di Ceuta del 1235, di Scio del 1347, di Cipro del 1373 e del 1402. C’est l’argent qui fait la guerre.
Dunque, sintetizzando un “riepilogo”, a seguito del consolidamento dell’organizzazione feudale, con la crescita del potere dei vescovi e dopo lo sviluppo dei liberi Comuni, Genova impose la sua preminenza – con le buone o le cattive – sulle altre comunità liguri. Nel 1254 riuscì a sottrarre pure Lerici all’influenza di Pisa e accrebbe il proprio controllo su quel Golfo, ma per quasi vent’anni, tra il 1256 e il 1273, il borgo della Spezia fu peraltro svincolato dal dominio genovese, poiché Nicolò Fieschi ne fece il centro di una propria ambiziosa ma effimera “signoria guelfa”, estesa da Lavagna a Sarzana, che ebbe termine con la conquista dell’ammiraglio Oberto Doria, il quale nello stesso tempo inviò vittoriosamente il fratello Jacopo contro i Grimaldi (Oberto è molto noto per aver comandato la flotta genovese nel trionfo della Meloria contro Pisa, sebbene affiancato dall’esperto Benedetto Zaccaria).
Genova incontrò le maggiori resistenze da parte dei Conti di Ventimiglia, dal Marchesato di Finale dei Del Carretto sottomesso solo nel 1713, da Savona in perenne lotta contro la filo-genovese Noli, e in alcuni momenti storici la sua supremazia sui territori fu necessariamente un po’ “a macchia di leopardo”…
Ma, partecipando attivamente alle Crociate (la nona ed ultima risale al 1272), poté diventare paladina baricentrica della Cristianità, così da ricavarne enormi benefici, assicurando la propria presenza commerciale e navale in tutto il Mediterraneo (divenuto intanto meglio navigabile in virtù dei progressi tecnologici delle flotte). Presso Caricamento affluivano non a caso tutte le merci che ora diremmo top di gamma, né è un caso che anche molte parole della gastronomia locale si leghino all’arabo, da buridda a bottarga, da mosciamme a scuccusun, o talvolta al francese, o al catalano… Le vittorie sul mare della Meloria contro Pisa (6 agosto 1284 con l’aiuto di 300 portorini), e della Curzola contro Venezia appena 14 anni dopo (1298), rinsaldarono la leadership genovese, ed anche la diarchia “ghibellina” Doria-Spinola, malgrado la terribile caduta di San Giovanni d’Acri (1291) in mano di un sultano mamelucco: Genova, che nel 1358 il Petrarca stesso andava definendo “Superba per uomini e per mura”, non a caso rimase la Repubblica marinara più potente del Mediterraneo dal XII al XIV secolo, una sorta di potenza pre-coloniale, nel 1252 emise il primo genovino d’oro, e “Ianuensis ergo mercator” (Genovese e quindi mercante) divenne espressione proverbiale, sebbene quel mercante si trasformasse poi progressivamente in banchiere, per godersi – meno temerariamente – finanze e palazzi, indirettamente “causando” il declino della città…
E’ medievale anche l’ulteriore espansione urbana a ponente, dove oggi s’incontrano rispettivamente Ponte Monumentale, Piazza Fontane Marose (dal nome di una fonte “impetuosa”, forse vicina ad un postribolo), la Lanterna – edificata nel 1139 ma il cui attuale aspetto risale al 1543 – , Montegalletto.
Con l’eccezione di una breve parentesi sotto i Visconti, la Francia e il Sacro Romano Impero, e poi di nuovo sotto i Visconti, Genova riuscì a riguadagnare pieno prestigio sulla ribalta politica con l’ammiraglio Andrea Doria (Oneglia, 1466 – Genova, 1560), che sgominò la – famosa – congiura dei rivali Fieschi (filo francesi) nel 1547, conquistando il castello di Montoggio grazie all’assedio del capitano Lercari. E che soprattutto seppe avvicinarsi alla Spagna di Carlo V e di Filippo II e a nuovi successi (siglos de oro), tanto che Genova cedette al potere enorme di Venezia e alle fatali mire dei Savoia solo alla fine della propria parabola di Stato autonomo… Era peraltro sopravvissuta ad anni difficili sulla scena internazionale, basti pensare che nel 1453 Costantinopoli, pur difesissima da mura, dopo lungo assedio s’era arresa ai turchi che disponevano del cosiddetto “cannone ottomano” consegnando loro l’intero impero bizantino; nel 1463 il Banco di San Giorgio (il “sostituto” delle Maone) aveva ceduto a Francesco I Sforza la proprietà della Corsica, sempre ribelle e continuamente appetita dai catalani (gli Sforza gliela restituirono nel 1484); e nel 1522 era stata saccheggiata dagli imperiali francesi…
“Capitale” di un territorio aspro, Genova necessitava (ieri come oggi) di connessioni, mancavano ancora 3 secoli all’introduzione delle ferrovie… Nel 1585 fu dunque aperta la strada della Bocchetta, sorta di “via del sale” per collegare Pontedecimo e la val Polcevera con Voltaggio e la val Lemme (la strada due secoli dopo fu adattata dal doge Giovan Battista Cambiaso ai carriaggi, divenendo “via Cambiagia”, ma dal 1823 perse d’importanza per via della costruzione della regia strada dei Giovi). Nel 1630, inoltre, una nuova, poderosa cinta di difese dalla Lanterna e dalla foce del torrente Bisagno salì lungo i crinali, disegnando profili di fortificazioni che preludono alla vista d’oggi ed alla città attuale.
Il temperamento della città da offensivo scadde tuttavia a tendenzialmente difensivo, i grandi palchi della storia si allontanarono (accenneremo fra poco a Cristoforo Colombo, genovese ma al soldo della Spagna), fu l’epoca delle congiure, delle fortificazioni sulle alture, degli attacchi di Carlo Emanuele I di Savoia prima, e di Carlo Emanuele II di Savoia in sèguito. Nel 1684 Genova, sempre filo spagnola, resisté anche per dieci giorni all’atroce cannoneggiamento francese dal mare, finalizzato ad esaurirne le forze e deprimere la popolazione, finché il doge Francesco Maria Imperiale Lercari dové prostrarsi a Versailles dinanzi alla potenza transalpina. Proseguirono inoltre – dal 1729 fino al 1768 – le insurrezioni in Corsica (indotte anche da epidemie, da carestie, e dall’iniquo sfruttamento fiscale genovese), che trovarono non pochi sostenitori anche all’esterno. Al termine, la Francia poté infatti “estorcere” l’isola a Genova…
Quanto a Savona, sottomessa da Genova nel 1528, quella città fuoriuscendo dal Medioevo conferiva al soglio due Papi, e ancora a metà Cinquecento – pur sofferente, ma “caratterizzata” da clamorose apparizioni mariane… – recitava sia un ruolo portuale (nella rada di Vado stavano alla fonda centinaia di navi le cui àncore reggevano ai ricorrenti libecci e scirocchi), sia di link con Piemonte e Padanìa, come ben focalizzò anche lo Chabrol (funzionario napoleonico) 3 secoli più tardi… Traffici, equipaggi, truppe animavano dunque anche le stagioni savonesi… Compulsando le pagine dell’illustre cronista Giovanni Vincenzo Verzellino (1562-1638), addirittura scopriamo che al Corpus Domini del 1543 l’imperatore Carlo V, salpato da Barcellona con una flotta impressionante, giunse (nuovamente) sulla riviera. Accolto con tutti gli onori, visitò a cavallo la nuovissima fortezza, prima di ripartire per Genova, sodale com’era – lo abbiamo appena scritto – di Andrea Doria. E 5 anni più tardi fu Filippo II, sempre con una flotta impressionante, a sostare (3 giorni) a Savona, ospitato a pranzo dai notabili, devoto alle Messe nel Santuario (la Madonna era apparsa 16 anni prima), ma incline – per esigenze di sicurezza – a dormire a bordo delle proprie galere. Non possiamo conoscere i raffinati menu che allietavano tali momenti di rappresentanza, ma certo ricevette in dono “molte conserve di zucchero (ovvero confetture) e altre gentilezze”. All’occorrenza, non dovettero mancare neppur i vini, se pochi anni dopo il poeta Gabriello Chiabrera, oziando nelle sue campagne di Legino, cantava di vigne e di vendemmie (paradisi per la vista e il palato che, peraltro, anche l’erudito Nicolò Cesare Garoni “confermò” nella sua Guida storica economica e artistica della città, 1874)…
5)Epoche moderna e contemporanea
Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo, “buscando el levante por el poniente” al soldo della corona spagnola, come noto scoprì l’America centrale (anziché le Indie) e successivamente, aprendosi quelle nuove rotte rivoluzionarie, cominciò per la Liguria e poi per Genova un periodo di decadenza. Acuitasi allorquando la Spagna stessa prese via via a soccombere dinanzi alle forze inglesi e olandesi (è del 1588 il tracollo della “invincible armada”, l’invincibile flotta spagnola vintissima dai colpi di Francis Drake, corsaro-politico, primo circumnavigatore inglese del globo…). Nel 1746 Genova fu occupata dagli Austriaci, e qui si collega il celebre episodio di Balilla (Giobatta Perasso), il giovinetto 11enne che a Portoria il 5 dicembre al grido “che l’inse!”, e scagliando un sasso, pare abbia incoraggiato la rivolta della città contro gli occupanti (alleati di Inghilterra, Olanda e Savoia, in un quadro confusissimo, contro Francia, Spagna, Prussia, Sassonia, Baviera e Regno di Napoli).
Nel 1805 la Liguria entrò a far parte dell’Impero napoleonico, furiosamente anticlericale (ma che talora inviò ottimi e lungimiranti funzionari, si pensi a Chabrol per Savona), e nel 1815 la regione fu poi annessa al Regno di Sardegna, sotto i Savoia (già possessori dal 1576 di Oneglia e dal 1736-1770 di Loano), per far infine parte dell’Italia unificata. Dopo i terremoti indotti dalle guerre bonapartiane, del resto, non v’era più spazio per staterelli e repubbliche che non fossero asserviti alle necessità delle potenze maggiori.
Peraltro la Liguria, com’è stato acutamente sottolineato, a differenza di tutte le altre regioni italiane non ha mai approvato l’annessione allo Stato sabaudo prima, e al Regno d’Italia poi, con plebisciti o altre forme di democrazia… Tale annessione, sancita dal Congresso di Vienna e operativa dal 7 gennaio 1815, fu perciò illegittima perché avvenuta in violazione dello scopo stesso per cui era stato convocato il Congresso, ovvero ristabilire le sovranità esistenti prima del 1797, e per la ferma contrarietà del legittimo e sovrano governo della Repubblica di Genova… Significativamente, aggiungo io, i forti costruiti dai Savoia a “difesa” di Genova vedevano le cannoniere rivolte non verso l’esterno delle mura ma verso l’interno, ovvero la città.
Sia come sia, dopo un primo momento di pesanti contrasti fra gli ex nemici, culminato con duri scontri urbani e la sanguinosa “calata” dei bersaglieri, le complementarità territoriali, sociali ed economiche diedero frutti, e i rispettivi interessi affiorarono palesi così da unire liguri e piemontesi nella emergente tensione risorgimentale, ed in seguito nella prospettiva unitaria. Di fatto Genova, col suo porto leader nel Tirreno, si elevò anche a vertice del cosiddetto “triangolo industriale” Ge-Mi-To.
Sul piano storico l’Ottocento fu dominato proprio dalle azioni insurrezionali del Risorgimento, che portarono all’Unità d’Italia (1861) e alla breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), le quali ebbero come protagonisti tanti personaggi liguri: Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Goffredo Mameli, Nino Bixio e molti altri patrioti irredenti. Tutto il secolo vide inoltre un intenso fervore imprenditoriale, agevolato anche dall’apertura del canale di Suez (1869) e dalla presenza a Genova di businessmen inglesi (che tra l’altro fondarono il Genoa cricket & football club) e tedeschi. Attraverso l’Ottocento prese poi vita il vero piano regolatore, con la sistemazione delle attuali Piazza De Ferrari, Via XXV aprile, Via Roma, la ripida Via Assarotti e la circonvallazione a monte, dove cominciarono a trasferirsi i facoltosi proprietari delle abitazioni del centro storico, sempre gravate – anche per l’attività del porto – da problemi igienico-sanitari. Si definì inoltre la fusione con le popolose aree di Quezzi e Marassi e con Albaro e Sturla…
Si noti che questa urbanizzazione, e il conseguente “operaismo”, in qualche modo coincisero se non produssero la nascita a Genova, presso la sala dell’associazione garibaldina Carabinieri genovesi, del Partito socialista (1892).
Fece però da contraltare a quanto sopra la poderosa emigrazione di liguri verso le “Meriche”, in primis l’Argentina, segno di una povertà che costringeva a partire, in cerca di maggiori fortune, verso l’ignoto. Questi liguri lasciarono in patria radici che tuttora consentono ritorni, all’insegna di una bilateralità culturale profonda, biografie mestieri musiche, si pensi anzitutto al barrio della Boca di Buenos Aires e ad alcune ricette “condivise” attraverso l’oceano…
Il fascismo, salito al potere (con la marcia su Roma del 1922) sfruttando anche il malcontento del primo Dopoguerra che covò sulla cosiddetta vittoria mutilata, non poté mai posizionare Genova fra le città più “devote” alla sua causa. Risale peraltro al 1926 l’accorpamento con Genova di tanti Comuni fino a quel momento autonomi, fra cui Sampierdarena, “la Manchester d’Italia”. E un regio decreto aveva 3 anni prima accorpato a ponente anche Oneglia e Porto Maurizio, gli empori dell’olio, dando vita alla realtà amministrativa di Imperia.
Durante la seconda guerra mondiale la Liguria fu pesantemente bombardata, e infine dopo l’armistizio dell’8 settembre occupata per due anni, dall’autunno 1943 al 25 aprile 1945, dalle forze naziste affiancate dal residuo fascismo della RSI (Repubblica Sociale Italiana), forze contrastate dalle azioni dei partigiani nascosti sui monti liguri. Genova, costringendo alla resa il generale tedesco Meinhold e dunque autoliberandosi, meritò al termine di quella terribile guerra civile la medaglia d’oro resistenziale.
Seguirono gli anni del boom economico, e di un’industria sempre “pesante” più che pensante, la quale asservì interi quartieri. Più di recente, anche grazie a progetti specifici, a “concause” e a finanziamenti ad hoc (mundial calcistico di Italia90, Colombiadi, Giubileo, G8 nel 2001, Capitale europea della cultura 2004…), Genova è andata legittimamente orientandosi al turismo culturale, una vocazione che potrebbe, se ben gestita, compensare le crisi industriali e lavorative che da decenni affliggono una città non più Superba – per ovvie ragioni – come ai tempi del Petrarca, ma in cerca di nuovi ruoli…
E in un certo senso, come sempre è avvenuto, al “destino” di Genova si legheranno forse anche i destini di molte altre territorialità liguri…
Umberto Curti
Suggerimenti bibliografici (in ordine alfabetico per cognome)
P.Baratono, Genova misteriosa – Scene di costumi locali, Genova, 1982
G.B.N. Besio, Genova e la Liguria nella storia, Genova, 1982
M.Bloch, La società feudale, Torino, 1999
F.Braudel, Mediterraneo, Milano, 2002
C.Brizzolari, L’inquisizione a Genova e in Liguria, Genova, 1974
C.M. Brunetti, Castelli liguri, Genova, 1967 (2^ ed.)
A.Cappellini, Dizionario biografico di Genovesi illustri e notabili, Genova, 1936
F.Cardini, L’età delle Crociate, in Storia illustrata di Genova, Genova, 1993
C.Costantini, La Repubblica di Genova nell’età moderna, Torino, 1978
U.Curti, Il cibo in Liguria dalla preistoria all’età romana, Genova, 2012
G.Delfino, Antichi giochi e danze, in La Casana, n. 4 (ottobre-dicembre 1975)
R.De Rosa, I Fieschi. Splendore e declino (1494-1709), Genova, 2004
F.Donaver, Storia di Genova, Genova, 1890
F.Ferraironi, Le streghe e il famoso processo di Triora del 1588, Roma, 1955
G.Ferraro, Leggende e racconti popolari della Liguria, Roma, 1984
G.Fiori, I Malaspina, Piacenza, 1995
G.Giacchero, Pirati barbareschi, schiavi e galeotti, Genova, 1970
P.Giardelli (a cura di), In treno da Genova a Casella, Genova, 1996 (2^ ed.)
E.Grendi, Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova, Genova, 1976
B.Lewis, I musulmani alla scoperta dell’Europa, Milano, 1983
P.Lingua, I Grimaldi, Milano-Novara, 1986
G.Marcenaro (a cura di), Fotografi liguri dell’Ottocento, Genova, 1980
G.Marcenaro, Viaggio in Liguria, Genova, 1992
D.G. Martini, Cristoforo Colombo, l’America e il teatro, Genova, 1988
M.Minola e B. Ronco, Castelli e fortezze di Liguria, Genova, 2006
C.Navone, La Congiura Fliscana. Montorio espugnato – 1547, in La Liguria illustrata, I(1913), n.8(agosto), pp. 450-466
F.Noberasco, I Savonesi illustri, Savona, 1939
G.Ottonelli, Storia di Genova, 3 volumi, Genova, 1978
E.Pandiani, Vita privata genovese nel Rinascimento, Genova, 1915
P.Pellizzetti, Dalle Maone all’impresa a rete, Torino, 2021
G.Petti Balbi, Genova medievale, Genova, 1978
G.Piccinni, I mille anni del Medioevo, Milano, 1999
E.Poleggi (a cura), Città portuali del Mediterraneo: storia e archeologia, Atti del Convegno Internazionale, Genova, 1989
L.Ponte, Le Genovesi, Genova, 2008
M.Porcella, Maggiolungo, storie dell’Appennino Ligure-Emiliano, Genova, 1996
A.Ronco, Luigia Pallavicini e Genova napoleonica, Genova, 1995
P.Stringa, I forti di Genova, Genova, 1985
S.Verdino (a cura di), Riviere in versi, Ventimiglia, 2002
G.V. Verzellino, Memorie e uomini illustri della città di Savona (1885), 2 volumi, Bologna, 1974