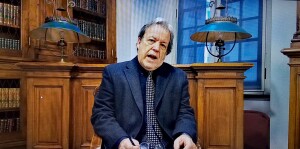5 dicembre giornata del suolo…, ricorre ogni anno dal 2014 – istituito dalla FAO – il World Soil Day, e, per così dire, nessuno più se ne senta escluso. L’intento infatti era, ed è sempre di più, di coinvolgere le popolazioni del mondo intero al fine di custodire suoli integri e garantire sostenibilità alle risorse da questi provenienti.
Le tematiche dell’anno in corso, in particolare, focalizzano ovviamente la salute del suolo, ovvero di quel sottile strato che sovrasta la crosta terrestre (senza esserne meramente la superficie), ma anche la sua resilienza (supportata dall’uomo), e la necessità di una pianificazione del futuro razionale e previdente – basata su monitoraggi e dati precisi – in termini politici.
Il suolo, nell’accezione che qui rileva, è il composto di quella miscela sommamente variabile di sostanza organica (viva o trasformata) e sostanza minerale che consente e sostiene la vita di piante ed animali.
Si badi, non a caso, che il 95% del cibo proviene all’uomo proprio dal suolo.
Peraltro, giungendo al 5 dicembre, a livelli europeo e italiano v’è ben poco di cui esser soddisfatti… Cementificazioni, dissesto idrogeologico, spreco idrico, pratiche agricole insostenibili costituiscono oggi come ieri – anche da allarmanti dati ISPRA – un pessimo viatico per l’avvenire del pianeta e della nostra vita.
Il suolo infatti, lo sappiamo bene, è risorsa non illimitata e non rinnovabile, ed il 33% del suolo globale – a fronte dei boom demografici di alcune aree… – è già degradato.
Senza una sua reale ed efficace salvaguardia aumenta direttamente, fra l’altro, il rischio di frane e alluvioni, e si compromette il più prezioso serbatoio di biodiversità toccatoci in sorte, essenziale anche – come detto – per la nostra alimentazione quotidiana. L’Italia risulta il Paese europeo con la maggior diversità di suoli, ma una legge chiara sul loro consumo sarebbe ormai improcrastinabile (acqua e aria sono già tutelate da direttive europee che ne assicurano il monitoraggio).
Chiunque si occupi di agricoltura sostenibile inquadra dunque l’urgenza di una lavorazione minima dei terreni, i quali invocano non le agricolture convenzionali ove ormai dipendenti da pesticidi ecc., bensì rotazione delle colture, aggiunta di materia organica, coltivazioni di copertura (diverse da quelle di reddito e finalizzate a migliorare i suoli)…, ciò che accrescerebbe la fertilità e la preservazione delle biodiversità, contrastando al contempo erosione, inquinamento e cambiamento climatico (sempre che i governi mondiali, specie quando si riuniscono, siano consci dell’emergenza e intendano fronteggiarla…).
Ancora una volta, sarebbe poi opportuno sottolineare (Ligucibario® lo fa da millenni…) anche il positivo ruolo della cosiddetta dieta mediterranea, la quale giova non solo alla salute umana, ma anche all’ambiente. Secondo un recente report specifico, a cura dell’Intergovernnemental Panel on Climate Change (Ipcc), sul climate change e l’uso dei suoli, quasi ¼ delle emissioni di gas serra di derivazione umana proviene da agricoltura, silvicoltura e altri usi dei suoli; dall’agricoltura, inoltre, proviene circa la metà delle emissioni di metano, ed essa risulta la principale fonte di protossido di azoto – due gas serra molto potenti – , mentre da dati FAO le emissioni di gas serra collegate all’allevamento sono il 14,5% di tutte quelle di origine antropica.
In tale contesto, la dieta mediterranea, centrata come noto sull’impiego frequente d’olio d’oliva, sulla nutrita presenza in tavola di frutta e verdura, di cereali e legumi, e su ragionevoli porzioni di pesce (più che carne), merita – anche in prospettiva – i più fondati riconoscimenti in termini di salubrità e di limitato impatto ambientale.
Umberto Curti